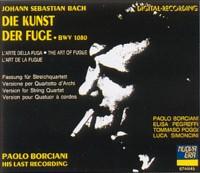|
| Domenico Scarlatti (1685-1757) |
Le vite dei musicisti non furono vissute dai titolari per essere raccontate ai posteri. Forse per questo sono affascinanti. Chi ha curato a puntino la propria autobiografia, sovente non è riuscito a trovare il tempo per lasciarci buone note. Tali vite, messe assieme, formano un campionario di alta umanità stravagante, un po' irrequieto, abituato a strizzare l'occhio ai piaceri mentre si dedica a composizioni sacre. Un'umanità spesso in viaggio, sempre dominata dalle note che ha concepito, composta da vite che hanno trasformato tutto il suono: sapori, odori, dubbi, debolezze e quella dose che tocca a ciascuno del fugace mondo dei sentimenti. Il 26 ottobre cade il terzo centenario della nascita di Domenico Scarlatti. Senza voler plagiare d'Ormesson, si può dire che "a Dio piacendo" è l'ultima ricorrenza di questo gonfio Anno della Musica. E' toccato a Scarlatti archiviare celebrazioni, auspici, saluti, comunicazioni, prolusioni, sottolineature, inchini e tutte quelle cose popolate dal nulla che hanno sostituito le vere iniziative (qualche felice eccezione conferma la regola). Si è frugato ancora una volta nelle vite dei musicisti ancora una volta si è parlato di un certo aspetto o della tal cosa. Le stesse dell'anniversario precedente. In Italia Scarlatti, nonostante tutto, sembra il meglio trattato. Si è tradotto finalmente il fondamentale Domenico Scarlatti di Ralph Kirkpatrick (ed. Eri) in novembre uscirà un denso e piacevole lavoro di Roberto Pagano, Scarlatti. Alessandro e Domenico: due vite in una (collana "Musica e storia", ed. Mondadori), che propone una vasta documentazione e qualche novità . Tra le iniziative degne di nota, vi è quella dell'"Associazione Amici del S. Maurizio", che a Milano ha organizzato una serie di incontri di estremo interesse. Dopo interventi di Piero Rattalino e di Giorgio Pestelli, il 17ottobre è stata la volta di Francesco Degrada, che ha parlato delle musiche vocali del nostro. Seguiranno le presenze del clavicembalista Kenneth Gilbert il 29 ottobre: è il caso di usare il plurale, giacché la sua giornata sarà divisa in un "corso di interpretazione" e in un concerto. Ma, al di là di tutto ciò , che cosa può dirci oggi Domenico Scarlatti? Occorre premettere ad ogni discorso che la sua biografia è abbastanza misteriosa. Molti si ricorderanno di quanto scrisse in proposito Massimo Bontempelli in Passione incompiuta: e cioè che tutti i poeti dovrebbero invidiare a Scarlatti "la fortuna di aver quasi fatto scomparire le tracce della sua vita quotidiana, di aver lasciato ai biografi poco o nulla da scovare, rimpinzare, diffondere...". Una vita che il musicista godette sino al possibile, per quel poco che ci risulta, spegnendola nel gioco e nelle irregolarità. Uno strano accordo di musica e carne, un vortice di passioni, ma anche un desiderio di discrezione. Poi una produzione immensa. Pagano ha ragione di inseguire l'uomo sui documenti brillanti e piacevoli, o di fiutarlo attraverso l'albero genealogico. Ma ha ancor più ragione quando mette in luce certi atteggiamenti del musicista fidandosi del proprio fiuto siciliano (a proposito di papà Alessandro Scarlatti, Pagano parla di una fragilità "radicata in quella Sicilia che ho ragione di conoscere meglio degli altri"). Tutto ciò, comunque, è ancora ben lontano dalla figura che fu Domenico. Nasce a Napoli, dove si presenta in società con L'Ottavia ristituita al trono del 1703, ma ben presto è a Firenze, a Roma, quindi a Venezia per ritoccare i propri studi con Francesco Gasparini e per incontrare Vivaldi ed Handel. Poi è di nuovo a Roma, si riempie la vita di melodrammi, è maestro di cappella presso la regina Maria Casimira di Polonia, quindi coadiutore in San Pietro, ed ancora maestro di cappella nella più grande chiesa della cristianità. Per continuare dovremmo trasferirci in Inghilterra, dove si reca con un Narciso rifatto poi in Portogallo, presso Giovanni V, per il quale compone musica sacra abbandonando il melodramma. Di nuovo in Italia, quindi in Spagna: Siviglia, Madrid. Ma pur in questi spostamenti ve ne sono altri e nel 1738 pubblica a Londra la raccolta dei 30 Essercizii per gravicembalo. La sua vita musicale la chiude con un Salve Regina, una delle più belle pagine sacre del Settecento. La sua anima però fu consegnata al corpus delle sonate: un blocco di 555 numeri, dei quali solo qualcuno vide la luce vivente Scarlatti. Nessuna di esse è stata datata dall'autore, nessuna ci è giunta in autografo. La loro cronologia, nonostante i meriti e gli sforzi della critica bene informata - ricordiamo ancora Kirkpatrick e Pestelli - resta un enigma. Ed un enigma è pure la divisione in tipi di sonate. Gerstenberg ne individuò tre fondamentali: monotematica, a gruppi di moti più o meno contrastanti tra loro e concatenati l'uno all'altro, a gruppi di motivi di cui la maggior parte è subordinata a una o più idee. Ma gli studi successivi si accorsero quanto fosse malsicura tale divisione, eccezion fatta per la monotematica (o sonata bipartita in un sol tempo). In esse abita un clima timbrico spagnolo, o meglio iberico, ed è innegabile la predilezione per certi intervalli tipici di quel mondo. L'orecchio più attento vi può scorgere imitazioni di chitarra e castagnette. Quanto alle fonti, restano ancora troppe cose da cercare e scoprire. Certe invenzioni dominate da un unico disegno ricordano Frescobaldi, certe altre sembrano ardite anticipazioni. C'è qualche filosofo che si è dedicato a ricostruire i collegamenti con i tocchi fragili e profondi di papà Alessandro, altri che non sono riusciti ad uscire dal labirinto che il gioco sapiente dei rimandi ha creato, e ancora lavorano. In verità ci si perde. E la colpa è forse della bizzarria, vera sovrana di quegli spartiti. Specchio sonoro di una vita, rifugio costruito da un'anima dedita ai piaceri ma amante della discrezione, le sonate sono il vero diario di Scarlatti, lo stesso che se fosse stato vergato a parole avrebbe fatto impallidire generazioni di storici della musica. Alberto Basso le ha definite un "miracolo di intelligenza", un fatto insolito partorito dal ventre del Settecento, quel secolo che vide il crepuscolo del clavicembalo e di certe profonde confessioni sonore. Forse è così. Ma Scarlatti si è rifiutato di confermare anche queste briciole. Quel Domenico talmente riservato che si pensò di traslare in gran segreto dall'abitazione madrilena in Calle di Leganitos al Convento di San Norberto. Per le normali operazioni di sepoltura, in un caldo giorno del luglio 1757.
Armando Torno
(Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 1985)